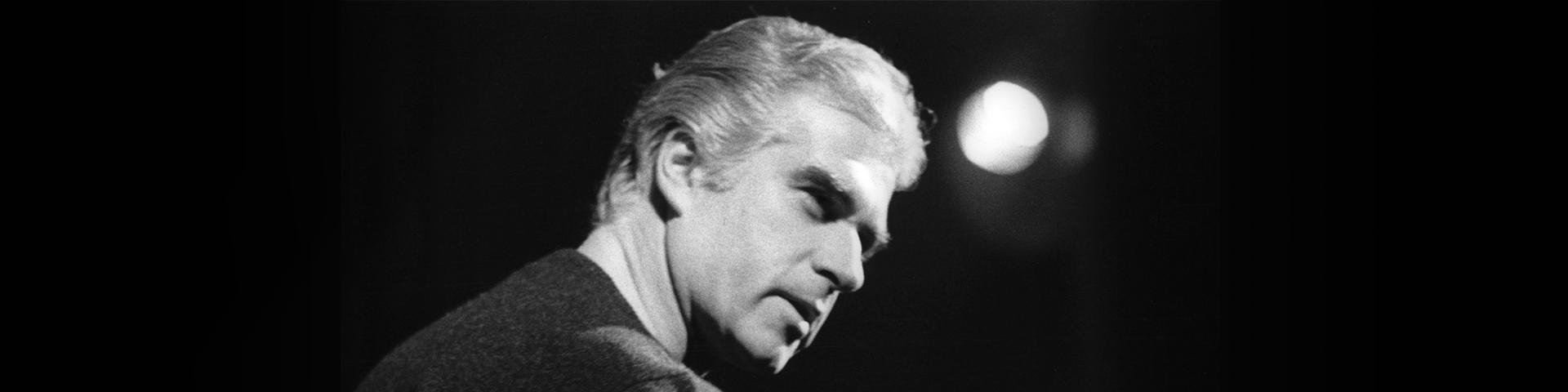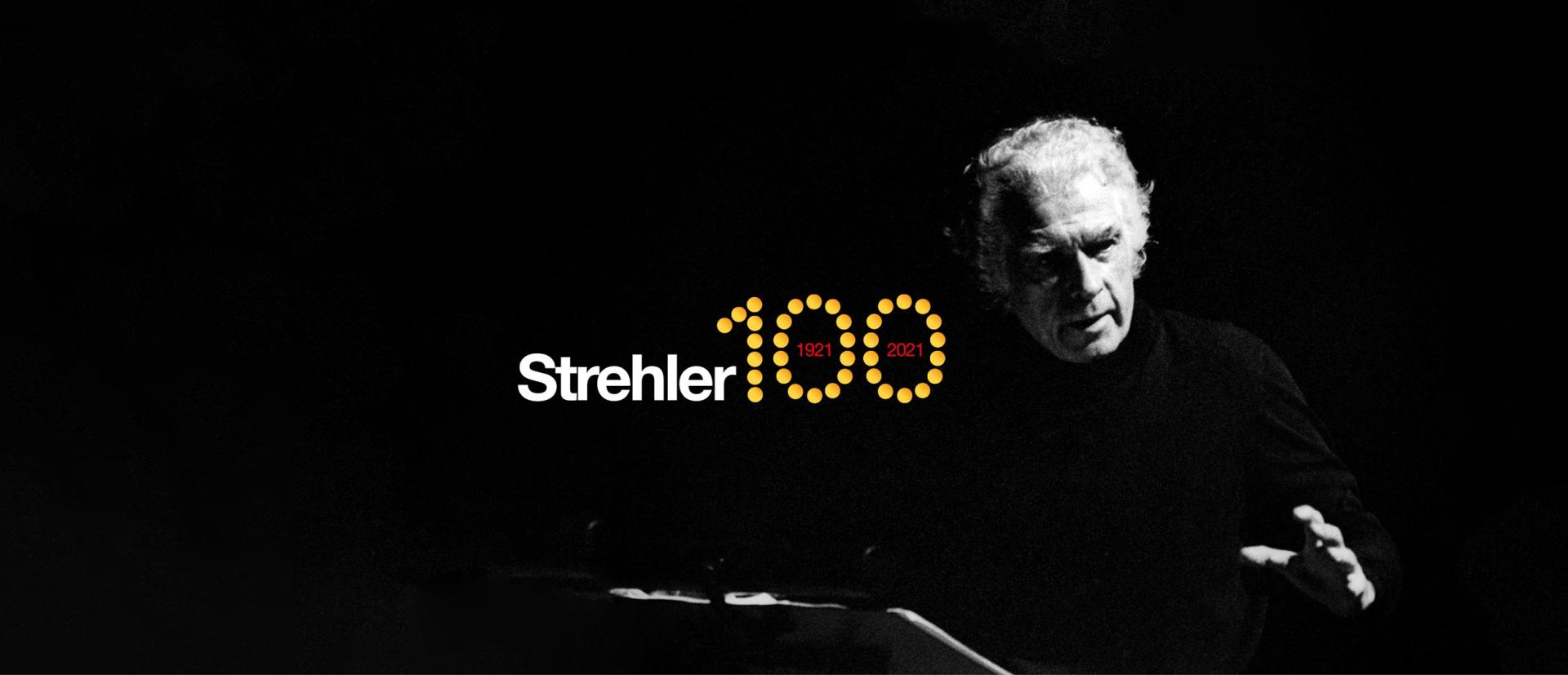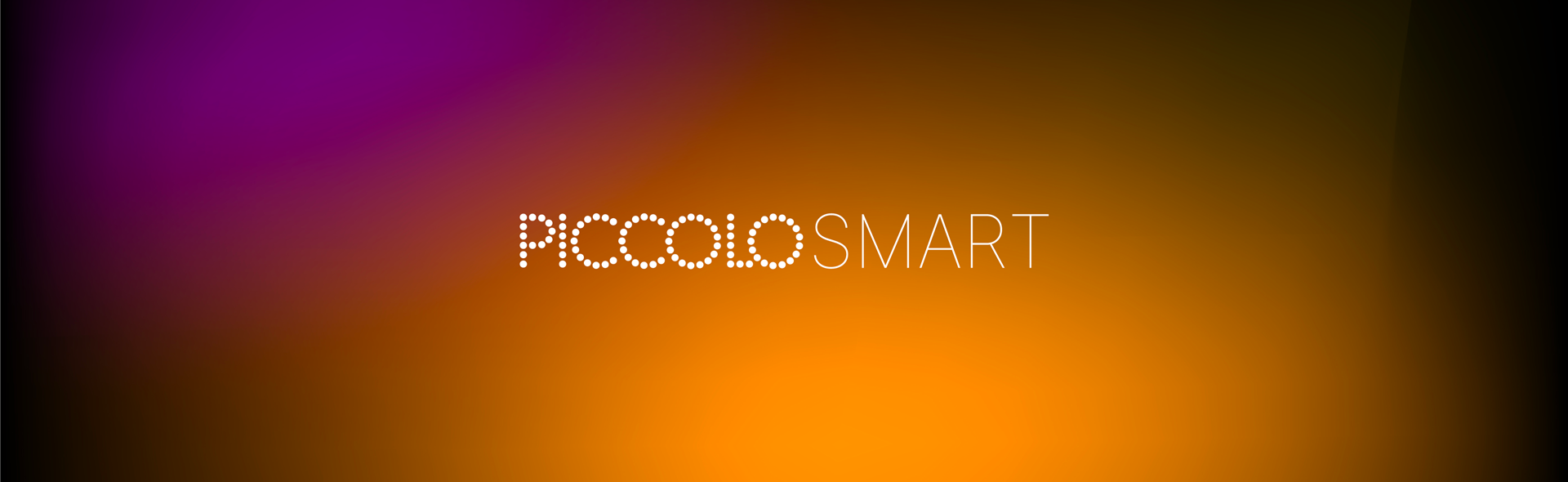Con il 14 agosto 2021 si è inaugurato l’anno dedicato alla celebrazione del centenario della nascita di Giorgio Strehler: per ricordare il suo fondatore, il Piccolo ha immaginato fino al 14 agosto 2022 una fitta e ricca trama di appuntamenti – tra mostre, testimonianze, spettacoli, incontri, pubblicazioni, video, la messa online del sito giorgiostrehler.it, convegni e documentari – fino a un’importante rassegna di spettacoli internazionali in presenza, il festival Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali) dal 4 al 31 maggio 2022, per riportare a Milano lo spirito dei grandi festival del Teatro d’Europa, ai quali proprio Strehler aveva dato impulso. Un palinsesto che disegna un quadro di collaborazioni e sintonie tra le realtà culturali della città, e non solo, con un respiro fortemente internazionale, un anno intero per ricomporre e far nuovamente risuonare tutte le sfumature di una voce essenziale della scena culturale novecentesca, con uno sguardo particolare al suo lascito alle giovani generazioni: la cultura come cardine intorno al quale ruota ogni possibile ricostruzione di un tessuto sociale, ogni vera ridefinizione di un sistema identitario, ogni consapevole apertura a una concreta prospettiva futura.
Apertura delle celebrazioni
Il 14 agosto 2021, con un’iniziativa d’apertura che ha intrecciato due momenti diversi, quello virtuale ma anche quello fisico, per iniziare insieme e in presenza il lungo viaggio attraverso gli sconfinati territori del teatro strehleriano, si è aperto lanno delle celebrazioni: è andato online il sito giorgiostrehler.it e, nell’ambito dell’Estate Sforzesca, al termine di una serata di letture con Stefano De Luca, Giorgio Bongiovanni e Umberto Ceriani, è stato proiettato lo speciale di Rai Cultura Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler, in onda anche su Rai5, dove è stato seguito dalla messa in onda della registrazione de Le baruffe chiozzotte (1966).
Il francobollo
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Giorgio Strehler nel centenario della nascita.
Il mio mestiere è raccontare storie
A ideale conclusione “in staffetta” della programmazione estiva del Piccolo, il 1° ottobre 2021 al Teatro Grassi una serata speciale, dal titolo Il mio mestiere è raccontare storie, ha proposto un ritratto del regista a tutto tondo, attraverso un collage di parole, musiche e immagini.
LA REGISTRAZIONE DELLA SERATA

Arlecchino, memoria vivente
Dal 12 al 31 ottobre 2021, al Teatro Grassi è andata in scena la ripresa dello storico allestimento di Arlecchino servitore di due padroni, regia di Giorgio Strehler, messa in scena da Ferruccio Soleri, con la collaborazione di Stefano De Luca.
SCOPRI
Le pubblicazioni
In occasione del centenario strehleriano, il Piccolo intraprende l’edizione del corpus degli scritti del regista: il percorso si è aperto con la pubblicazione di Lettere agli italiani, una silloge con una trentina di contributi di Giorgio Strehler – per lo più apparsi su alcuni dei principali quotidiani italiani fra il 1975 e il 1996 – incentrati su temi di politica tout court e politica culturale, presentata nel novembre 2021 a “BookCity”. Il secondo titolo in programma è l'edizione di Shakespeare, Goldoni, Brecht, raccolta di testi di Giorgio Strehler dedicata ad alcuni degli autori più frequentati dal regista. Entrambi i titoli sono pubblicati in partnership con il Saggiatore.
lEGGI TUTTO
Rimanendo in ambito editoriale, sono stati pubblicati altri libri che approfondiscono, da diversi punti di vista, l’universo del regista triestino.
SCOPRI I TITOLI
Strehler sullo schermo
Tre sono i prodotti realizzati ex novo per raccontarne la parabola artistica e il magistero teatrale di Giorgio Strehler: in ordine cronologico, Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler, progetto editoriale di Felice Cappa e regia di Marco Odetto, produttore esecutivo Serena Semprini a cura di Giulia Morelli, nell'ambito della Media Partnership tra il Piccolo e Rai Cultura; Essere Giorgio Strehler, realizzato da 3D Produzioni, con la regia di Simona Risi, su soggetto di Didi Gnocchi e sceneggiatura di Matteo Moneta e Gabriele Raimondi; Strehler com'è la notte? con la regia di Alessandro Turci, scritto insieme a Federica Miglio e Antonia Ponti, una coproduzione Dugong Films e Rai Documentari.
sCOPRI DI PIù
Strehler e i palcoscenici milanesi
Nonostante la natura effimera del teatro, il lavoro di Giorgio Strehler ha lasciato numerose tracce: non solo fotografie e manifesti, ma anche oggetti di scena, costumi, copioni, documenti autografi, appunti di regia, disegni tecnici ed elementi di scenografia. Un vero e proprio tesoro custodito negli archivi, solitamente non accessibile, che è stato reso disponibile al pubblico con l’intento di ripercorrere, in un viaggio esperienziale e conoscitivo, la vicenda artistica e creativa del Maestro. In collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano e la Fondazione Corriere della Sera, è nata così la grande mostra Strehler e i palcoscenici milanesi, articolata in due sezioni.
SCOPRI DI PIù
Strehler città aperta
Instaurare un dialogo con la collettività, con il momento storico, con le realtà culturali che innervano il tessuto urbano, nella convinzione che, proprio a partire dal rafforzamento dei rapporti con il territorio e la propria comunità di riferimento, si possa costituire quella base identitaria che ci consente di guardare lontano, di portare il proprio agire teatrale, culturale e – prima di tutto – umano, oltre i confini locali e persino nazionali. Il rapporto di Giorgio Strehler con la città di Milano non si è mai esaurito semplicemente con l’esperienza del Piccolo, ma è sempre vissuto all’insegna di una costante ricerca di dialogo, di ascolto reciproco con tutti coloro che contribuivano a trasformare il vivere cittadino in un vivere civile attraverso l’esercizio del proprio impegno culturale. Nel mettere a frutto questo straordinario insegnamento nell’anno del centenario strehleriano, il Piccolo organizza una serie di appuntamenti che si articoleranno nell’arco dell’intera stagione 2021/2022. Una partitura di incontri nel segno del grande regista, dove gli enti, le fondazioni, le diverse identità culturali cittadine saranno chiamate a essere interpreti attivi di una messa in scena collettiva, a restituire una pluralità di voci e di sguardi su Strehler, sulla sua opera e sulla sua eredità, in quello che non vuole essere un semplice omaggio al Maestro, ma la continuazione e l’ampliamento di una conversazione vivissima, caleidoscopica e ininterrotta con il contemporaneo e le sue specificità.
LE ISTITUZIONI COINVOLTE
Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali)
Dal 4 al 31 maggio 2022 il Piccolo organizza un grande festival internazionale, in presenza, dedicato a Giorgio Strehler. Registi e compagnie da vari paesi del mondo portano spettacoli negli spazi del Piccolo e in vari luoghi della città. Il mondo torna ad attraversare Milano e Milano a essere il centro del mondo grazie al teatro, al potere della cultura di polverizzare i confini e a un dialogo internazionale, che il Piccolo si propone di rendere sempre più fitto e continuo nelle prossime stagioni.
SCOPRI IL PROGRAMMA
Il lavoro teatrale di Giorgio Strehler a cent’anni dalla sua nascita
Lunedì 25 ottobre 2021, il Piccolo e l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, diretto da Alberto Bentoglio), hanno promosso una giornata di studi dal titolo Il lavoro teatrale di Giorgio Strehler a cent’anni dalla sua nascita, per sviluppare una riflessione teatrologica sul percorso, sul lascito e sull’attualità del regista. Gli interventi sono stati affidati a giovani studiosi, che, per ragioni anagrafiche, non hanno potuto assistere agli spettacoli del Maestro e che sono stati chiamati a confrontarsi con le tematiche del teatro di regia strehleriano, dal rapporto con i testi e i grandi autori, alla collaborazione con l’attore, fino alla progettazione della messinscena. L’evento, coordinato dalla prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi, ha avuto luogo nella Sala Napoleonica dell’Università ed è stato seguito, al Chiostro Nina Vinchi, da un ciclo di incontri di approfondimento, anche attraverso la proiezione di video d’archivio, rivolto agli studenti della Statale.
CONSULTA IL PROGRAMMA
V Convegno internazionale EASTAP
Il V Convegno internazionale EASTAP, a cura di Alberto Bentoglio, Claudio Longhi e Daniele Vianello, sarà ospitato dal Piccolo e dall’Università degli Studi di Milano dal 23 al 27 maggio 2022. In collaborazione con Università degli Studi di Milano, Università della Calabria, Università Ca’ Foscari di Venezia e CUT (Consulta Universitaria del Teatro), con il patrocinio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università IULM di Milano, il Convegno – che comprende anche l’Emerging Scholars’ Forum, una nuova piattaforma rivolta a dottorandi, studenti universitari e giovani studiosi all’inizio della carriera, per incontrarsi, presentare i propri progetti di ricerca e discuterne – si sviluppa in dialogo con gli eventi proposti dal programma Strehler100, in particolare nella cornice del Festival Internazionale dedicato a Strehler nella primavera 2022.
SCOPRI DI PIù
giorgiostrehler.it
Il 14 agosto 2021 il Piccolo ha inaugurato giorgiostrehler.it, il sito internet dedicato al Maestro e concepito come una mostra virtuale sul lavoro del regista, luogo di approfondimento didattico per le scuole, mappa digitale dell’intero progetto Strehler100. Si tratta di un “contenitore” che non ha solo la funzione di “vetrina” e archivio delle differenti azioni messe in campo ma costituisce, esso stesso, una ulteriore modalità operativa, contribuendo a moltiplicare le prospettive di sguardo sull’“universo Strehler”.
SCOPRI DI PIù
#strehler100
Sui profili social del Piccolo, dal 1° gennaio 2021 è iniziato un racconto per valorizzare i molteplici aspetti della personalità di Giorgio Strehler, del suo lavoro di regista, del suo rapporto con Milano, l’Italia, l’Europa e il mondo.