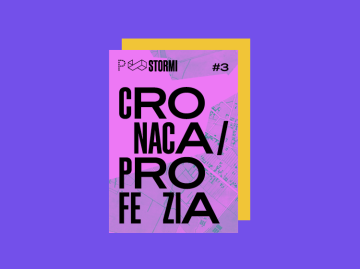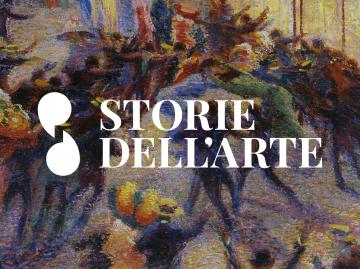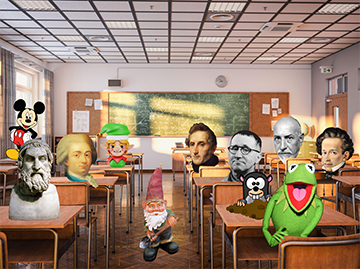Lo spettacolo è stato pensato – spiega il regista Carmelo Rifici – «per dare a un gruppo di giovani l’opportunità di mettersi alla prova su una drammaturgia di Michele Santeramo e tratta dal romanzo pubblicato da Elio Vittorini nel 1945». Il testo racconta le vicende di un gruppo di partigiani durante l’occupazione nazifascista di Milano.
Diretto da Carmelo Rifici, Uomini e no è stato pensato e creato – spiega il regista – «per dare a un gruppo di giovani attori l’opportunità di mettersi alla prova in un repertorio non tradizionale, con una drammaturgia scritta da Michele Santeramo e tratta dal romanzo che Elio Vittorini pubblicò nel 1945».
Ambientato a Milano tra la primavera e l’autunno del 1944, il testo racconta le vicende di un gruppo di partigiani impegnati in una serie di azioni di contrasto all’occupazione nazifascista della città. «La scelta di Uomini e no – continua Rifici –, condivisa con Stefano Massini e Sergio Escobar, si inserisce nella proposta di drammaturgia contemporanea del Piccolo Teatro. Eravamo interessati a un testo che parlasse di Milano e fosse anche fertile terreno di lavoro sulla lingua italiana, dal momento che doppiaggio, cinema e tv hanno spesso snaturato il rapporto delle ultime generazioni di attori con la lingua letteraria. Milano è il luogo realistico e metaforico insieme in cui svolgono sia gli eventi storici narrati sia la vicenda umana di Enne 2, il protagonista – dietro al quale si intuisce il pensiero dello stesso Vittorini – impegnato a combattere contro un se stesso sempre meno umano».
I protagonisti di Uomini e no sono ragazzi intorno ai vent’anni, scaraventati nella tragedia della guerra civile, in un mondo reso talmente caotico dal conflitto. Eppure, incredibilmente, gli eventi tragici da cui sono travolti regalano a quei giovani una sorta di stupore.
«I venticinquenni di oggi– conclude Rifici – hanno quello stesso stupore? Volevo che recuperassero un elemento immaginifico, antico, scaturito da una realtà storica che dovrebbe ancora toccarci. Vittorini ci aiuta a riscoprire una sorta di meraviglia, nell’amore, nell’amicizia, nei rapporti umani, che apparteneva a un’epoca così complessa come la prima metà del Novecento ma oggi è inesorabilmente andata perduta».
All’uscita del romanzo Elio Vittorini fu oggetto di forti critiche, a partire dal titolo stesso che sembrava dividere le due parti coinvolte nel conflitto in “umana” e “disumana”. In realtà l’opera di Vittorini, tutt’altro che banalmente manichea, è complessa, a tratti ambigua, e perciò estremamente attuale.
«Il testo – conclude Rifici – ha il dono di mostrare il contagio della violenza, malattia che ammorba entrambe le fazioni nella direzione di una pericolosa somiglianza. Oggi è molto difficile rintracciare contrapposizioni ideologiche tanto estreme: purtroppo quel germe di indifferenziazione cui allude Vittorini è esploso in tutta la sua evidenza».
Durata: due ore e 18 minuti compreso intervallo
Diretto da Carmelo Rifici, Uomini e no è stato pensato e creato – spiega il regista – «per dare a un gruppo di giovani attori l’opportunità di mettersi alla prova in un repertorio non tradizionale, con una drammaturgia scritta da Michele Santeramo e tratta dal romanzo che Elio Vittorini pubblicò nel 1945».
Ambientato a Milano tra la primavera e l’autunno del 1944, il testo racconta le vicende di un gruppo di partigiani impegnati in una serie di azioni di contrasto all’occupazione nazifascista della città. «La scelta di Uomini e no – continua Rifici –, condivisa con Stefano Massini e Sergio Escobar, si inserisce nella proposta di drammaturgia contemporanea del Piccolo Teatro. Eravamo interessati a un testo che parlasse di Milano e fosse anche fertile terreno di lavoro sulla lingua italiana, dal momento che doppiaggio, cinema e tv hanno spesso snaturato il rapporto delle ultime generazioni di attori con la lingua letteraria. Milano è il luogo realistico e metaforico insieme in cui svolgono sia gli eventi storici narrati sia la vicenda umana di Enne 2, il protagonista – dietro al quale si intuisce il pensiero dello stesso Vittorini – impegnato a combattere contro un se stesso sempre meno umano».
I protagonisti di Uomini e no sono ragazzi intorno ai vent’anni, scaraventati nella tragedia della guerra civile, in un mondo reso talmente caotico dal conflitto. Eppure, incredibilmente, gli eventi tragici da cui sono travolti regalano a quei giovani una sorta di stupore.
«I venticinquenni di oggi– conclude Rifici – hanno quello stesso stupore? Volevo che recuperassero un elemento immaginifico, antico, scaturito da una realtà storica che dovrebbe ancora toccarci. Vittorini ci aiuta a riscoprire una sorta di meraviglia, nell’amore, nell’amicizia, nei rapporti umani, che apparteneva a un’epoca così complessa come la prima metà del Novecento ma oggi è inesorabilmente andata perduta».
All’uscita del romanzo Elio Vittorini fu oggetto di forti critiche, a partire dal titolo stesso che sembrava dividere le due parti coinvolte nel conflitto in “umana” e “disumana”. In realtà l’opera di Vittorini, tutt’altro che banalmente manichea, è complessa, a tratti ambigua, e perciò estremamente attuale.
«Il testo – conclude Rifici – ha il dono di mostrare il contagio della violenza, malattia che ammorba entrambe le fazioni nella direzione di una pericolosa somiglianza. Oggi è molto difficile rintracciare contrapposizioni ideologiche tanto estreme: purtroppo quel germe di indifferenziazione cui allude Vittorini è esploso in tutta la sua evidenza».
Durata: due ore e 18 minuti compreso intervallo
Incontri e approfondimenti
La Locandina
Piccolo Teatro Studio Melato
dal 24 ottobre al 19 novembre 2017
Uomini e no
di Michele Santeramo
tratto dal romanzo “Uomini e no” di Elio Vittorini
regia Carmelo Rifici
scene Paolo Di Benedetto
luci Claudio De Pace
costumi Margherita Baldoni
musiche Zeno Gabaglio
con (in ordine alfabetico) Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Alfonso De Vreese, Salvo Drago, Caterina Filograno, Yasmin Karam, Leda Kreider, Marta Malvestiti, Benedetto Patruno, Matteo Principi, Marco Risiglione, Elena Rivoltini, Livia Rossi, Martina Sammarco, Francesco Santagada, Sacha Trapletti, Annapaola Trevenzuoli
produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa
Questo spettacolo è parte del Premio Giornalistico Nazionale di Critica Teatrale, concorso riservato a redattori e redattrici culturali under 36 promosso dal Network Lettera 22. Per informazioni clicca qui.
PRODUZIONE - SERIE STAGIONE
SPETTACOLO IN ABBONAMENTO
Acquista online gli abbonamenti "Oro" cliccando qui
Platea:
Intero € 33,00 | Ridotto giovani e anziani € 21,00 | Bambini € 12
Balconata:
Intero € 26,00 | Ridotto giovani e anziani € 18,00 | Bambini € 12
L’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a prezzo ridotto riservati ai bambini fino ai 12 anni, ai giovani under 26 e agli anziani over 65 si può effettuare esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Strehler (largo Greppi, M2 Lanza) oppure tramite biglietteria telefonica al n. 02.42.41.18.89.
On line si possono acquistare soltanto i biglietti a prezzo intero oppure accedere alle eventuali promozioni in corso.
Informazioni e prenotazioni
Servizio telefonico 02.42.41.18.89
da lunedì a sabato 9.45-18.45; domenica 10-17.
Teatro Strehler
da lunedì sabato 9.45-18.45 continuato; domenica 13-18.30
Nelle serate di spettacolo la prevendita dei biglietti è sospesa a partire da un'ora prima della rappresentazione
Gruppi e pubblico organizzato
Per informazioni su biglietti e abbonamenti per i gruppi organizzati, per le scuole, spettacoli educational, rivolgersi al Settore Promozione Pubblico e Proposte Culturali.
tel. 02 72.333.216
e-mail: promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it